La sindrome di Sanremo: lo odiamo, lo guardiamo, lo commentiamo
C’è un momento preciso, ogni anno, in cui anche chi giura di non guardarlo finisce davanti al televisore. Magari anche solo “per vedere gli abiti”. O, più onestamente, per poter dire la propria il giorno dopo.

È quella cosa che critichi con ironia, ma che se non segui ti lascia una strana sensazione di esclusione.
Per chi, come me, è nato negli anni ’80, Sanremo non è solo un Festival. È un sottofondo emotivo. È la voce della televisione accesa in salotto.
Sanremo è il nostro rito collettivo travestito da gara canora. E funziona ancora, nonostante tutto.
Sì, sto ripassando la semantica tanto studiata nel mio percorso universitario e ho voglia di descrivere Sanremo così, parlando di “orizzonte d’attesa”: quell’insieme di aspettative che portiamo con noi prima ancora che qualcosa accada. Sanremo vive di questo. Prima ancora che inizi, sappiamo già che ci sarà una polemica, un abito divisivo, una performance che spaccherà l’opinione pubblica.
E noi siamo lì, pronti a interpretare.
Sanremo non crea solo spettacolo. Crea senso condiviso.
Perché lo critichiamo ma lo guardiamo?
Sanremo è mainstream, e tutto ciò che è mainstream diventa automaticamente bersaglio.
È nazionalpopolare, e quindi chiunque si sente legittimato a dire la sua — dal critico musicale improvvisato al cugino che “la musica vera era quella degli anni ’90”.
È lungo, lunghissimo, quasi epico (anche se lo scorso hanno è andato a velocità x2). E questa dilatazione è il suo superpotere: più ore, più momenti memorabili, più scivoloni, più meme.
Sanremo non è solo uno spettacolo. È materia prima per la conversazione collettiva.
E poi c’è quella cosa che fingiamo di non avere: la FOMO (acronimo di “Fear Of Missing Out”, letteralmente “paura di essere tagliati fuori”).
Perché puoi anche decidere di non guardarlo, ma il giorno dopo sei comunque dentro al flusso.
Ti arrivano i meme su WhatsApp.
Leggi le citazioni fuori contesto.
Ti imbatti nell’outfit virale mentre scorri Instagram.
Qualcuno commenta “hai visto cosa è successo ieri?” come se fosse cronaca nazionale.
Anche chi dice “non lo guardo mai” sa perfettamente chi ha stonato, chi ha vinto e quale abito ha diviso l’Italia in due.
Perché Sanremo, che lo ammettiamo o no, ci riguarda.
Il fenomeno di costume.
Ogni edizione funziona come un laboratorio pop a cielo aperto: comprime tendenze, linguaggi, tensioni sociali e le rimette in circolo amplificate. In una sola settimana succede quello che altrove impiega mesi.
Nascono trend musicali che poi dominano le playlist per un anno intero.
Spuntano espressioni che diventano tormentoni nazionali nel giro di una notte.
Emergono figure che entrano stabilmente nell’immaginario collettivo, al di là della classifica finale.
Si accendono dibattiti che travalicano la musica e toccano temi sociali, identitari, generazionali.
A distanza di anni possiamo dimenticare un podio, ma non dimentichiamo cosa quell’edizione ha raccontato di noi. E, diciamolo, nemmeno il gossip che l’ha attraversata.
Perché Sanremo è l’unico posto in cui puoi iniziare la serata parlando di tonalità e finirla discutendo di imprevisti, drammi, polemiche e uscite di scena degne di una serie tv.
Nel 2024, l’abbandono improvviso del palco da parte di Morgan durante la serata dei duetti ha oscurato per qualche ora qualsiasi discorso tecnico sulle canzoni. Timeline impazzite, clip condivise ovunque, analisi psicologiche non richieste. La classifica? Dettaglio secondario. Il momento? Memorabile.

E andando indietro nel tempo, durante le edizioni condotte da Pippo Baudo, il Festival è stato segnato anche da episodi legati a tentativi di suicidio (reali? Non lo sapremo mai, qualcuno ha dei dubbi) che hanno interrotto bruscamente la leggerezza dello spettacolo. Momenti che hanno trasformato per qualche minuto il palco in qualcosa di completamente diverso: non più solo intrattenimento, ma realtà che irrompe in diretta nazionale. E sì, anche quelli sono rimasti impressi molto più di tante canzoni in gara.
Ma Sanremo sa essere memorabile anche senza scandali. Nel 1995, quando Giorgia vinse con “Come saprei”, non è rimasta impressa solo la vittoria. È rimasto il momento. Quella voce che sembrava alzare l’asticella per tutti. Quel tipo di talento che, anche se non ricordi l’ordine esatto del podio, ti ricordi dov’eri quando l’hai sentito. E all’improvviso Sanremo non era più solo “la gara”, ma un passaggio di livello per la musica italiana.

Sanremo è questo strano equilibrio: glamour e imprevisto, spartiti e fuori programma, paillettes e umanità che traballa. È un evento che promette spettacolo, ma che ogni tanto scarta di lato — e forse è proprio lì che diventa impossibile distogliere lo sguardo.
Perché il Festival non è solo una gara. È una narrazione in tempo reale. E noi, da bravi spettatori cresciuti con la tv accesa in salotto, sappiamo benissimo che il momento che “salta il copione” è quello che resta.
Moda, identità e potere simbolico sul palco dell’Ariston
E tutto comincia da una scala.
Quella discesa lenta, studiata, sospesa tra attesa e giudizio, è forse il momento più carico di significato dell’intera serata. Prima ancora di cantare, prima ancora di parlare, si scende. E in quei pochi secondi si decide un racconto.
Negli ultimi anni la moda ha smesso di essere contorno ed è diventata narrazione pura. Gli abiti manifesto di Chiara Ferragni non erano semplicemente vestiti: erano dichiarazioni. Le performance sartoriali di Achille Lauro non erano solo outfit: erano identità messe in scena.


Ma è proprio sulla scala che tutto si attiva.
La scala è rito di passaggio. È esposizione. È vulnerabilità travestita da glamour. È il momento in cui l’Italia trattiene il fiato e valuta in silenzio — o twitta compulsivamente.
Ogni passo è un segno. Ogni tessuto è un messaggio. Ogni silhouette è una presa di posizione.
Sanremo è contemporaneamente vetrina couture, strategia di branding personale, linguaggio politico e moltiplicatore social. Nessuna passerella tradizionale può competere con quella scalinata che trasforma una discesa di pochi metri in un evento nazionale.
Un look può essere più memorabile della canzone stessa. A volte lo è.
Perché l’abito, su quel palco, non è mai solo estetica. È storytelling visivo. È costruzione identitaria. È leva PR. È un modo per dire “eccomi” prima ancora di aprire bocca.

Le canzoni passano.
La scala resta.
E forse è proprio lì, tra un gradino e l’altro, che Sanremo diventa quello che è davvero: un grande rito collettivo in cui ogni anno saliamo, scendiamo, giudichiamo, applaudiamo.
Sipario.






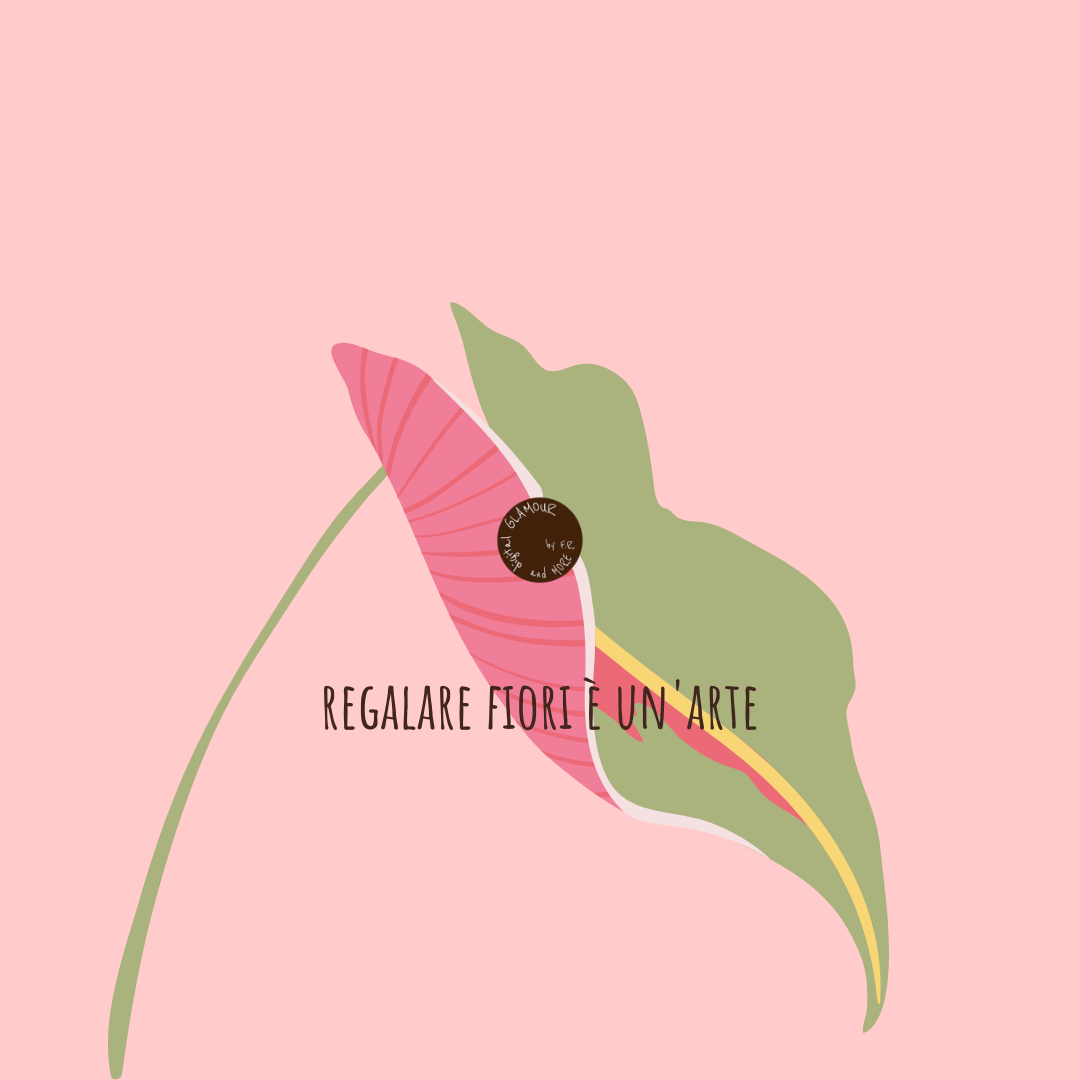

Scrivi un commento